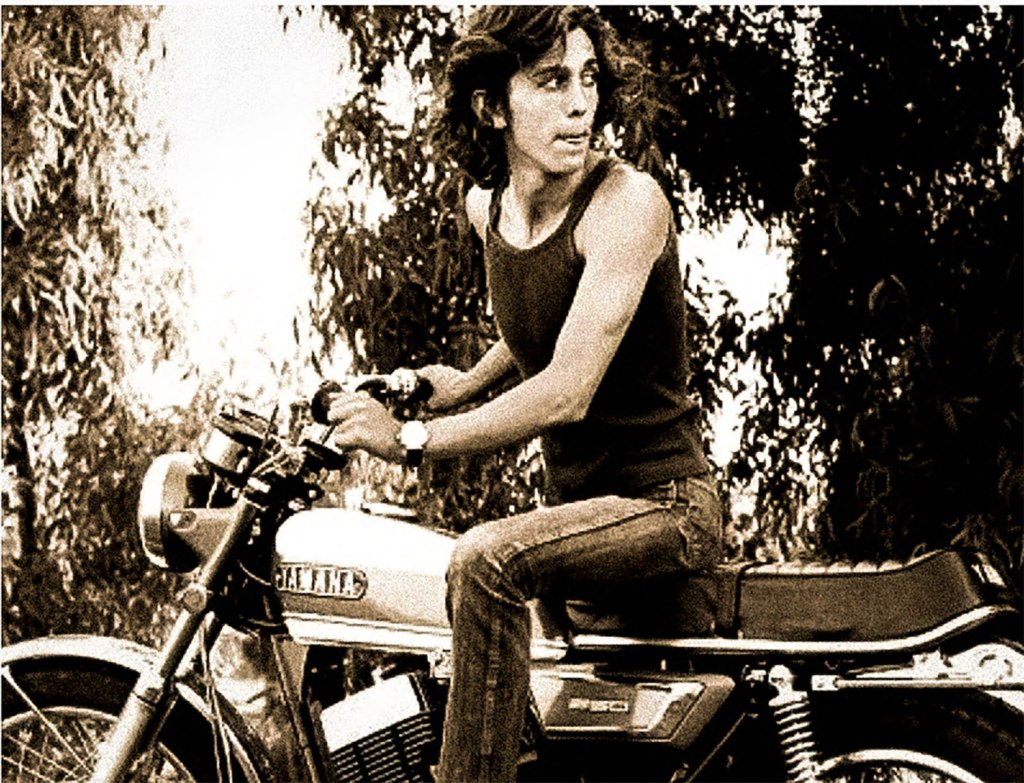
“Enrico Blasi, sei tu, proprio tu? E mi riconosci?” Così, senza preamboli, come se il tempo fosse nulla, solo inutile polvere sui mobili, mi accolse Donatella, la sorella del mio antico compare Gianfranco, sul piazzale assolato davanti alla casa. Riconoscerla? Un’impresa ardua, considerando che in famiglia contavano otto pargoli, cinque maschi e tre femmine, una vera e propria tribù. E per noi, allora, freschi di pubertà e con le ginocchia ancora sbucciate, le ragazze erano entità nebulose, figuriamoci le sorelle degli amici, creature aliene che popolavano un altro pianeta. Eravamo troppo occupati con le nostre scorribande adolescenziali, le battute di caccia improbabili nei boschi, gli scherzi talvolta crudeli, la goffa fascinazione per moscardini e volpi, la conquista effimera di qualche granchio di terra. Insomma, la riconobbi con un certo ritardo, ma lei, la memoria di ferro, rammentava ogni mia bravata, ogni infantile nefandezza: la loro vasca dei pesci, vittima innocente di un masso lanciato con mira imprecisa dalla strada (tra le urla scomposte di fratelli e sorelle), la burla crudele e altrettanto mal riuscita ai danni di un altro inquilino del palazzo. Ricordava persino la mia inconsistenza di allora, ero trasparente, un nano insignificante nel suo orizzonte di ragazza che già guardava altrove, verso lidi più maturi. Le femmine, si sa, bruciano le tappe, e i loro sguardi si posano volentieri su esemplari maschili ben più rodati di quella nostra sgangherata banda di maschietti in erba.
Un’oretta di strada tra Selinunte e Bartolino, che sommata ai cinquant’anni e passa trascorsi, un’esistenza intera, in cui ognuno aveva diligentemente coltivato il proprio orticello di gioie e dolori. Eppure, ritrovarci lì, nel “buen retiro” di Gianfranco, come se il tempo fosse stato un’illusione ottica, riprendere conversazioni interrotte mezzo secolo prima, scambiandoci occhiate complici su certi aneddoti sbiaditi, senza la melassa della nostalgia né il livore del rancore, è stata una sorpresa piacevole, quasi un piccolo miracolo laico. La tenacia di un’amicizia antica, capace di scavalcare le inevitabili divergenze della vita per concentrarsi su quel poco o tanto che ancora ci teneva legati. E così, racconti che si accavallavano, descrizioni minuziose di un mondo perduto, progetti vaghi per un futuro incerto, colazioni frugali, pranzi pantagruelici e cene conviviali, con loro due e con il resto della famiglia a fare da coro: il nipote Francesco, placido e bonario, i due nipoti scapestrati e la moglie Nastia, con la sua aria vagamente esotica. Quella frase, “sei a mezz’ora di strada da casa mia”, l’avevo accolta con una certa cautela, domandandomi se fosse un sincero desiderio di rivederci o una semplice formalità, un tic di cortesia. Ripensandoci ora, nulla di grave ci aveva mai separato, nessuna lite furibonda, solo un progressivo allontanamento, la distrazione degli affari quotidiani, i diversi interessi che germogliano con l’età, il lavoro che assorbe energie, le donne che irrompono nel paesaggio emotivo… e il nulla di tutti quegli anni silenziosi. È stato come un viaggio a ritroso nel tempo, un’immersione nelle radici comuni. Lui, Gianfranco, seduto all’ombra di un albero secolare, con il suo tablet sulle ginocchia, un cordone ombelicale virtuale che lo teneva legato a una miriade di contatti sapientemente coltivati, annunciava al mondo il nostro improbabile ricongiungimento, la mia inaspettata apparizione a Pineta Molinari. Eravamo lì, vivi e vegeti, seduti allo stesso tavolo, mentre Donatella, con la tenacia di un aedo, dipanava la saga della loro famiglia, un affresco di un mondo a me sconosciuto, storie di legami familiari e di una società che sembravano strappate dalle pagine del Gattopardo, alternate a narrazioni più terrene e viscerali, degne della penna di un Verga. Una Sicilia e una “sicilianitudine” inimmaginabile, ormai dissolta, polverizzata dal progresso. Ricordi che affioravano come reliquie, rimpianti sussurrati a mezza voce, orgoglio ancestrale e improvvise esplosioni di ilarità, una vita vissuta intensamente, esposta senza filtri, senza le ipocrisie di una falsa modestia. Come non capire, come non apprezzare questo fiume in piena di umanità? Stavamo assistendo a una sceneggiatura vivente, un film in costume che si dispiegava davanti ai nostri occhi, immagine dopo immagine. Avrei voluto avere un registratore, una telecamera, ma rimasi immobile, quasi temessi che un gesto potesse incrinare la magia di quel racconto orale. Ero certo che il flusso delle parole si sarebbe inaridito, trasformandosi in un meccanico resoconto, perdendo la sua forza primigenia, la sua autenticità.
Naturalmente, era un’overdose di storie, un’indigestione di aneddoti di cui non potrei mai ricordare ogni dettaglio, ma le emozioni suscitate, quelle sì, si sono impresse nella mia memoria come un sigillo indelebile. Era come se avessi vissuto anch’io tra le mura austere dei palazzi di Sciacca e di Palermo, percepito il fruscio austero delle vesti della nonna, respirato l’odore acre e il calore afoso delle terre arse dal sole, assaporato la generosità dei frutti della loro campagna, assistito alle piccole astuzie dei contadini, ricevuto la severa educazione di un tempo. La grande famiglia siciliana, un racconto epico, quasi omerico, che spero, un giorno non lontano, qualcuno avrà la saggezza di trasferire sulla carta, sottraendolo all’effimera fragilità della memoria.