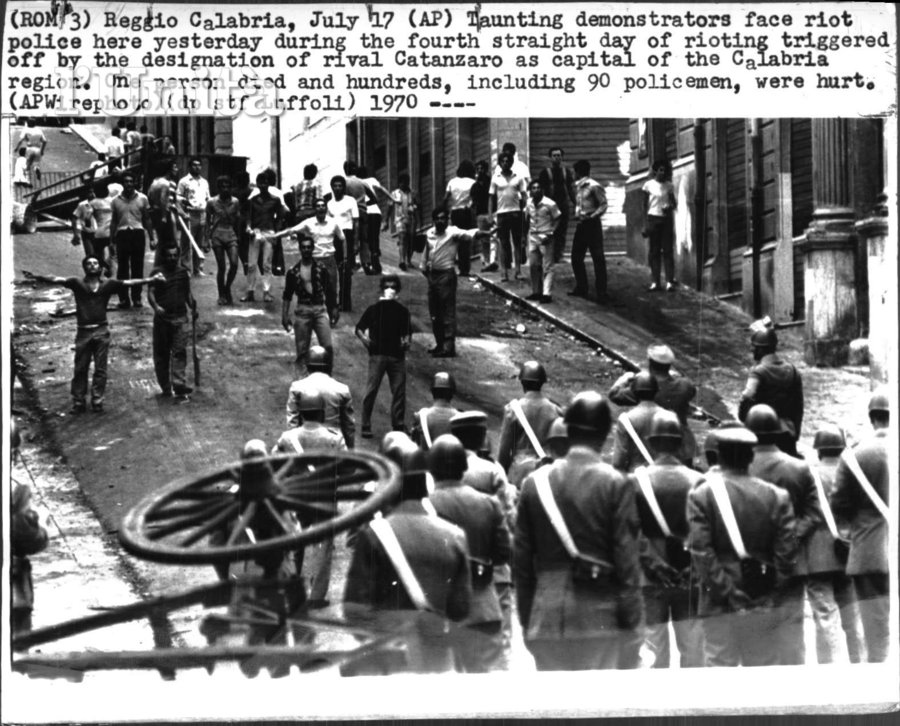
Ah, l’estate, quella breve parentesi tra un lavoro e l’altro, un brodo di niente in cui a volte galleggia qualche imprevisto saporito. Luglio, dicevamo? Un mese come tanti, un sole che picchiava sulla carrozzeria della 125 di Vladi, un’auto potente e generosa, come spesso sono le cose prestate, che ci portava, me e quell’anima quieta di Ennio, verso Taormina. Un miraggio, un lavoro improvviso e imprevisto che ci portava nel profondo sud: settecentocinquantadue chilometri di asfalto bollente. Troppi, naturalmente. E la rettitudine non era il nostro forte, si sa. Luciano, un vecchio complice di bagordi e strani viaggi a scrocco, s’era piantato in Calabria, aveva radici importanti, di quelle che affondano nella terra e nel potere. Una masseria, un piccolo borgo di case sparse, l’aria satura di zagare e un’aia assolata. Perfetto per una deviazione, no? Taormina poteva aspettare, il lavoro, si sa, è un’ombra che insegue, non scappa. E poi c’erano loro, tre francesi smarrite nel Sud, e il bambino di Marie Helene, Olivier, piccolo orfano di un recente incidente stradale. L’atmosfera era languida, il cibo fragrante, il vino generoso e il mare… beh, il mare era un invito alla follia. Isabel, con quella sua inconfondibile cadenza francese, intonava “Era il 38 luglio…”, una nostra privata litania di gioventù e demenza. Un paio di giorni così, sospesi tra l’ozio e la risacca, e poi di nuovo in marcia verso la Sicilia. Settimana sbrigativa, lavoro consegnato, quattrini incassati. E la strada che si ripresentava tale e quale, monotona e assolata. “Ma perché non ripassiamo da Luciano?” buttò lì Ennio, con quell’aria vaga di chi ha un pensiero fisso che gli ronza intorno. Forse una gonna svolazzante, forse un sorriso. E poi c’era Marie Helene, certo, una bellezza discreta, di quelle che non urlano ma restano impresse. Tornammo indietro, errore madornale. La stanchezza era un macigno, le notti brevi annaffiate di caffè e vodka non aiutavano. E da Luciano trovammo la sagra del notabilato locale, una processione di figure paludate, perfino un alto prelato, tutti schierati ai lati di una tavolata infinita sotto il portico. La sera era un vapore caldo, il vino consolatorio. Io seduto accanto a Marie Helene, e dall’altro lato un damerino impomatato che le sussurrava oscenità con un ghigno compiaciuto, scavalcandomi con la noncuranza di chi si crede il padrone del mondo. Lei, straniera o brava attrice, lo ignorava con la più nordica dignità gelida. La situazione si fece presto elettrica. “Basta!” sbottai, alzandomi di scatto. Tutti gli occhi puntati addosso. Il damerino sguainò un coltello con una rapidità inquietante. Io afferrai una bottiglia, la ruppi sul tavolo e mi feci avanti. “Vieni fuori, qui facciamo scandalo” mi sfidò, avviandosi. Stavo per seguirlo, la testa annebbiata dalla rabbia, quando Luciano mi bloccò: “Sei pazzo? Se esci sei morto, quello è uno dei capi del ‘boia chi molla’, e fuori ci sono i suoi gorilla”. Un bel guaio, davvero. “Dovete andarvene, subito, prima che si organizzino” ci incalzò Luciano. “Anche le ragazze”. Inutile dire che la colpa, in quel consesso di anime pie, ricadde interamente sulle mie spalle. Perfino la madre di Luciano e il prelato non mancarono di rimproverarmi. Ehm si, avevo dato scandalo. Decisione rapida. Valigie sulle auto, Ennio al volante della 125 con Isabel e Monique, io a quello dell’Alpine di Marie Helene, l’auto che il damerino e la sua accolita conoscevano bene. Fuga rocambolesca da un ingresso secondario, io davanti a tutta velocità, Ennio a pochi minuti di distanza. Ero io il bersaglio, chiaro come il sole di luglio. L’Alpine, per fortuna, era un auto truccata, da competizione, quindi un vero fulmine, e io, diciamocelo, parecchio spericolato. Ci immettemmo in autostrada mentre due auto tentavano di sbarrarci la strada, come in quei film americani un po’acciaccati. Inseguimento folle, un’Alfetta alle calcagna. Non mollai l’acceleratore. L’Alfetta incollata, i tentativi di sportellata quando rallentavo per i camion, un braccio armato che spuntava dal finestrino. E in tutto quel caos, Olivier, un anno appena, dormiva beato in una micro amaca appesa dietro, mentre Marie Helene, rannicchiata, si nascondeva il viso tra le mani, terrorizzata. Un incubo su quattro ruote. Arrivammo a Salerno al limite, rischiando un tamponamento a catena dietro una curva. I freni tennero, ma le gomme urlarono il loro addio all’asfalto. Gli inseguitori, per fortuna, avevano desistito chissà da quanto, anche se io, preso dalla fuga, non me n’ero neppure accorto. Era il 38 luglio, cantavano gli Squallor, faceva un caldo porco. Già, effettivamente.
Roma ci accolse con la sua indolenza consueta. L’adrenalina si era sciolta come neve al sole, la notte da incubo un ricordo sbiadito. Ennio ci raggiunse ore dopo, con calma, e anche loro avevano avuto qualche incontro ravvicinato, ma il bersaglio ero io, quindi li avevano lasciati perdere. E la vita romana riprese il suo corso pigro: sveglie a mezzogiorno, caffè al bar, pizza al taglio dall’altoatesino di via della Suburra. Passeggiate svogliate in piazza, notti brave per mostrare alle francesi la “vera Roma”, quella del “che c’hai cento lire?”, “passami na sigaretta”, “che famo, c’annamo?”. Una città bonacciona, scroccona, perdigiorno. Come noi, del resto. E ogni sera il rito, in pellegrinaggio per cornetti caldi e “grattachecche” dalla sora Maria a via Trionfale, poi all’Isola Tiberina, e a notte fonda al “Ristoro della salute”, un posto coloniale sbiadito davanti al Colosseo, stucchi africaneggianti e una fauna discutibile. Il Colosseo, si sa, era terra di nessuno, soprattutto di notte. Però, i frullati di frutta… i migliori del mondo. Una notte, anzi, l’una passata, mentre eravamo in fila alla cassa, qualcuno allungò una mano maldestra sul fondoschiena di Marie Helene. Certo, era un bel vedere, ma lei non gradì. Uno schiaffo sonoro fu la sua risposta, gesto che non piacque all’energumeno di turno. Lei si rifugiò dietro di me: “Blasi, difendimi!”. Non feci in tempo a capire, un pugno violento mi stese tra le cassette di frutta. Ero diventato, suo malgrado, il cavaliere senza paura. E dire che era stata solo la stanchezza, il vino… da sobrio, forse, avrei evitato. Due, tre, quattro giorni romani e poi “faceva troppo caldo, e anche qui era scoppiata l’afa”. Destinazione Vulcano, dove Luciano, che non se l’era presa (e ci mancherebbe altro), ci aspettava. Partenza da Napoli su un traghetto sgangherato, stipato di gente. Basta autostrade e basta Reggio Calabria. Vulcano era srepitosa, un’esplosione di colori e profumi: alberi carichi di fiori, mimose gialle, il mare azzurro e immobile, le acque sulfuree, i fanghi. Bagni rigeneranti nel fango tiepido, la pelle che tirava al sole, poi un tuffo nel mare per lavare via tutto. Di giorno, di notte, sotto le stelle. La pelle diventava liscia come seta. “Senti, senti qui che pelle…” A forza di sentirci statuari, morbidi, levigati, successe quello che doveva succedere. Eravamo giovani, belli quanto basta, allegri, disimpegnati (io con un piede già fuori dal matrimonio) e, diciamocelo, sessualmente attraenti. Ci abbandonammo al piacere, e fu bellissimo, anche se effimero. Ognuno aveva la sua vita, chi in Italia, chi in Francia. Ma quell’estate, a Vulcano, sotto le stelle, il tempo si era fermato un istante, regalandoci uno scampolo di felicità, leggera e spensierata. Come spesso accade, le cose più belle sono quelle che durano un battito di ciglia. Rientrammo con la stessa nave, dormendo in coperta tra mille altri infilati nei sacchi a pelo, con la pelle di seta e la testa di sogni.